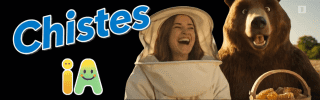Biologia
|
|
Título del Test: Biologia Descripción: Biologia pd |



| Comentarios |
|---|
NO HAY REGISTROS |
|
1. Secondo la teoria cellulare moderna, il materiale genetico nelle cellule: è condiviso da tutte le cellule. contiene solo informazioni sullo sviluppo delle cellule. è necessario solo per la riproduzione cellulare. contiene le Informazioni ereditarie necessarie alla cellula per svilupparsi, accrescersi e riprodursi. 2. Il ruolo principale dell'adenosintrifosfato (ATP) nelle cellule è: l'ATP funge da precursore nella produzione di adenosina. l'ATP agisce come una sorta di moneta o pila energetica, catturando e trasferendo energia nelle cellule. l'ATP svolge un ruolo chiave nella sintesi degli acidi nucleici. l'ATP è coinvolto principalmente nella produzione di molecole lipidiche. 3. La differenza fondamentale tra gli autotrofi e gli eterotrofi in termini di fonti di nutrimento è: gli autotrofi si nutrono di altri organismi, mentre gli eterotrofi producono il loro nutrimento. gli autotrofi producono il loro nutrimento utilizzando l'energia solare, l'acqua e il diossido di carbonio, mentre gli eterotrofi si nutrono di sostanze prodotte da altri organismi. gli autotrofi e gli eterotrofi utilizzano lo stesso meccanismo per ottenere il loro nutrimento. gli autotrofi si nutrono solo di animali, mentre gli eterotrofi si nutrono solo di piante. 4. I due principali tipi di reazioni metaboliche cellulari sono le: reazioni anaboliche e reazioni cataboliche; le reazioni anaboliche sintetizzano molecole complesse e richiedono energia, mentre le reazioni cataboliche demoliscono molecole complesse e liberano energia. reazioni cataboliche e reazioni sintetiche; le reazioni cataboliche sintetizzano molecole complesse e richiedono energia, mentre le reazioni sintetiche demoliscono molecole complesse e liberano energia. reazioni endergoniche e reazioni esergoniche; le reazioni endergoniche sintetizzano molecole complesse e richiedono energia, mentre le reazioni esergoniche demoliscono molecole complesse e liberano energia. reazioni anaboliche e reazioni catatoniche; le reazioni anaboliche sintetizzano molecole complesse e liberano energia, mentre le reazioni catatoniche demoliscono molecole complesse e richiedono energia. 5. Il ruolo principale degli enzimi nelle reazioni biochimiche all'interno delle cellule è: indurre reazioni chimiche. assorbire energia dalle reazioni chimiche. accelerare le reazioni chimiche senza essere modificati permanentemente. agire come substrati nelle reazioni chimiche. 1. Le principali macromolecole biologiche tra quelle indicate qui di seguito sono: carboidrati, lipidi, vitamine. proteine, carboidrati, lipidi. glucosio, amminoacidi, nucleotidi. ossigeno, idrogeno, azoto. 2. La principale differenza strutturale tra il glucosio e il ribosio è la seguente: il glucosio ha sei atomi di carbonio, mentre il ribosio ne ha cinque. il glucosio ha un gruppo carbonilico, mentre il ribosio ha un gruppo ossidrilico. il glucosio ha un doppio legame tra gli atomi di carbonio, mentre il ribosio no. il glucosio ha un atomo di ossigeno in meno rispetto al ribosio. 3. La principale differenza tra gli acidi grassi saturi e quelli insaturi: gli acidi grassi saturi contengono doppi legami carbonio-carbonio, mentre gli insaturi no. negli gli acidi grassi saturi tutti i legami di ogni atomo di carbonio sono saturati con atomi di idrogeno, negli insaturi no. gli acidi grassi saturi si trovano solo nei lipidi, mentre gli insaturi si trovano solo nei carboidrati. gli acidi grassi saturi sono presenti solo nelle piante, mentre gli insaturi solo negli animali. 4. Il ruolo principale dei carotenoidi: assorbire la luce. convertire la luce in ATP. favorire la sintesi proteica. stimolare la fotosintesi. 5. Le vitamine sono considerate nutrienti essenziali per il corpo umano perchè: sono prodotte dal corpo in quantità sufficienti per soddisfare i fabbisogni. sono coinvolte principalmente nella produzione di energia nelle cellule. il loro deficit può portare a sindromi da deficienza che possono essere curate o prevenute con la loro somministrazione. svolgono principalmente funzioni strutturali all'interno delle cellule. 1. Due amminoacidi formano un legame peptidico tramite: un gruppo ossidrilico interno e un gruppo aminico terminale. un gruppo ossidrilico terminale e un gruppo fosfato. due gruppi carbossilici. un gruppo aminico terminale e un gruppo carbossilico terminale. 2. Gli acidi nucleici, DNA ed RNA, presentano alcune differenze: il contenuto percentuale del pentoso. una base pirimidinica e lo zucchero pentoso. il pentoso ed una base purinica. l'assenza nell'RNA di adenina. 3. I nucleotidi che costituiscono la catena di RNA formano tra di loro un: legame a idrogeno. legame glicosidico. legame fosfodiesterico. legame idrofobico. 4. Le proteine sono costituti da amminoacidi che formano una catena: polinucleotidica tramite legami petidici. polipeptidica tramite legami fosfodiesterici. polinucleotidica tramite legami ad idrogeno. polipeptidica tramite legami peptidici. 5. Le due funzioni fondamentali del DNA sono: sintesi di RNA e proteine. duplicazione del materiale genetico e sintesi di amminoacidi. conservazione dell'energia e produzione di RNA. immagazzinamento delle informazioni genetiche e duplicazione del DNA. 1. Streptococchi, spirilli e vibrioni sono: nomi dei primi tipi di batteri identificati. nomi di batteri dovuti alle specifiche proteine della loro parete. nomi di batteri determinato dal comparto dell'organismo che infettano. nomi di batteri determinati dalla loro forma. 2. Il DNA plasmidico è: una molecole di DNA circolare in grado di replicarsi autonomamente nei batteri. una molecola di DNA circolare che si replica dopo trasduzione nei batteri. una molecola di DNA che codifica geni della replicazione di DNA nei batteri. una molecola di DNA circolare coinvolta nella scissione binaria batterica. 3. La ricombinazione genica nei batteri può avvenire tranite la coniugazione che prevede il: trasferimento di DNA da una cellula ad un'altra grazie all'intervento di un batteriofago trasducente. trasferimento di DNA, derivato da una cellula morta, ad un'altra cellula ricevente. trasferimento di DNA da una cellula ad un'altra grazie all'intervento di un ponte citoplasmatico. trasferimento di DNA, derivato da una cellula morta, lisata da un batteriofago. 4. A quale tipologia di divisione cellulare vanno incontro i batteri: mitosi. scissione binaria. coniugazione. meiosi. 5. La ricombinazione genica nei batteri può avvenire tranite la trasduzione che prevede il: trasferimento di DNA da una cellula ad un'altra grazie all'intervento di un batteriofago trasducente. trasferimento di DNA, derivato da una cellula morta, ad un'altra cellula ricevente. trasferimento di DNA da una cellula ad un'altra grazie all'intervento di un ponte citoplasmatico. trasferimento di DNA da una cellula ad un'altra grazie all'intervento di un plasmide. 1. Streptococchi, spirilli e vibrioni sono: nomi dei primi tipi di batteri identificati. nomi di batteri dovuti alle specifiche proteine della loro parete. nomi di batteri determinato dal comparto dell'organismo che infettano. nomi di batteri determinati dalla loro forma. pd. 2. Il DNA plasmidico è: una molecole di DNA circolare in grado di replicarsi autonomamente nei batteri. una molecola di DNA circolare che si replica dopo trasduzione nei batteri. una molecola di DNA che codifica geni della replicazione di DNA nei batteri. una molecola di DNA circolare coinvolta nella scissione binaria batterica. pd. 3. La ricombinazione genica nei batteri può avvenire tranite la coniugazione che prevede il: trasferimento di DNA da una cellula ad un'altra grazie all'intervento di un batteriofago trasducente. trasferimento di DNA, derivato da una cellula morta, ad un'altra cellula ricevente. trasferimento di DNA da una cellula ad un'altra grazie all'intervento di un ponte citoplasmatico. trasferimento di DNA, derivato da una cellula morta, lisata da un batteriofago. pd. 4. A quale tipologia di divisione cellulare vanno incontro i batteri: mitosi. scissione binaria. coniugazione. meiosi. pd. 5. La ricombinazione genica nei batteri può avvenire tranite la trasduzione che prevede il: trasferimento di DNA da una cellula ad un'altra grazie all'intervento di un batteriofago trasducente. trasferimento di DNA, derivato da una cellula morta, ad un'altra cellula ricevente. trasferimento di DNA da una cellula ad un'altra grazie all'intervento di un ponte citoplasmatico. trasferimento di DNA da una cellula ad un'altra grazie all'intervento di un plasmide. pd. 1. Si definisce limite di risoluzione: la distanza massima al di sopra della quale siamo in grado di vedere due punti distinti. la distanza tra due punti distinti espressa in micrometri. la distanza che deve separare due punti affinchè l'occhio li percepisca come punti distinti. la distanza tra due punti distinti espressa in nanometri. 2. Il sistema di membrane interne e l'involucro nucleare potrebbero aver avuto origine: da un processo di endosimbiosi. da ripiegamenti della membrana del reticolo endoplasmatico liscio. da ripiegamenti della membrana nucleare. da ripiegamenti della membrana plasmatica. 3. Nell'apparato di Golgi giungono le proteine che: sono state sintetizzate da ribosomi liberi. sono state sintetizzate da ribosomi legati al reticolo endoplasmatico. non sono funzionanti e che saranno poi distrutte dai lisosomi. sono destinate al reticolo endoplasmatico. 4. In una cellula eucariotica il DNA è contenuto: nel nucelo, nei mitocondri, nei ribosomi. nel nucleo e nei mitocondri. nel nucleo e nei ribosomi. nel nucleo. 5. La cellula eucariote ha in comune con la cellula procariote: nucleo, membrana plasmatica, mitocondri, reticolo endoplasmastico, citoscheletro e matrice extracellulare. DNA, membrana plasmatica, ribosomi, lisosomi, reticolo endoplasmastico. DNA, membrana plasmatica, ribosomi, citoplasma, citoscheletro. nucleoide, parete cellulare, ribosomi citoplasma, mitocondri. 1. Si definiscono 'fagi' : gruppo di virus resistenti agli antibiotici. gruppo di virus a RNA. gruppo di virus che infettano i batteri. abbreviazione di macrofagi, riferito alla risposta immunitaria che i virus scatenano in un organismo. 2. I virus si differenziano dai batteri perchè: hanno un metabolismo più semplice. non sono in grado di replicarsi autonomamente. presentano una ridotta complessità delle loro proteine. hanno unp specifico meccanismo di duplicazione del DNA. 3. La replicazione dei retrovirus prevede l'intervento di un'enzima specifico: la trascrittasi inversa per trascrivere l' RNA virale in un intermedio a DNA. la trascrittasi inversa per permettere l'integrazione nel DNA della cellula ospite. l'RNA polimerasi per trascrivere il genoma virale in un intermedio a RNA a doppio filamento. l' RNA polimerasi per sintetizzare le copie del DNA virale. 4. Secondo la classificazione di Baltimore i genomi virali possono essere distinti: in base al loro stato di infettare solo piante o solo animali. in base alla loro struttura chimica, che può essere DNA a doppia o singola elica o RNA a singolo filamento. in base al loro riconoscimento da parte dei capsomeri. in base alla loro forma. 5. Durante il ciclo lisogenico dei batteriofagi: il profago si stacca dal cromosoma dell'ospite. il DNA virale si replica insieme al DNA dell'ospite. il virus cambia la sua forma da profago a capside. la cellula ospite cresce in maniera ottimale. 1. Una delle principali caratteristiche della DNA polimerasi è quella di: allungare una catena polinucleotidica di un filamento di DNA in un'unica direzione in presenza di un RNA primer. allungare un filamento di RNA, a partire da un DNA primer, solo in direzione 5'-3' lungo la forca di replicazione. legare una specifica sequenza promotore per trascrivere un filamento di RNA complementare ad uno solo dei due filamenti di DNA. avviare la replicazione conservativa del DNA catalizzando legami fosfodiesterici tra nucleotidi liberi. 2. Esistono tre meccanismi cellulari di riparazione del DNA: riparazione per escissione, correzione di bozze, riparazione di anomalie di appaiamento. riparazione silente, riparazione missenso, riparazione nonsenso. correzione di bozze, riparazione frameshift, riparazione per escissione. tramite chaperoni molecolari, riparazione di bozze mediata da elicasi, tramite i telomeri. 3. Alcuni tipi cellulari, come le cellule germinali e le cellule staminali, riescono a dividersi a lungo grazie alla: modificazione del ciclo cellulare. conservazione del DNA telomerico. meiosi. mitosi. 4. La sintesi del filamento lento durante la duplicazione del DNA procede: in modo continuo e in avanti verso la forcella di repicazione. in modo discontinuo e a ritroso iniziando dall'RNA primer più distante rispetto alla forcella di replicazione. in modo continuo e in avanti iniziando dall'RNA primer più lontano rispetto alla forcella di replicazione. in modo discontinuo senza l'ausilio dell'RNA primer. 5. La funzione principale della primasi durante il processo di duplicazione del DNA è: sintetizzare l'RNA primer in direzione 5' -> 3' sul filamento stampo di DNA. eliminare il primer alla fine della duplicazione del DNA. legare covalentemente i nucleotidi al filamento preesistente durante la duplicazione. sintetizzare il nuovo filamento di DNA durante la duplicazione. 1. Indicare l'ordine corretto con il quale l'informazione genetica fluisce nelle cellule: 1) l'informazione codificata nella sequenza delle basi del DNA passa ad una particolare sequenza di basi dell'RNA, 2) l'informazione dell'RNA passa ai polipeptidi. 1) l'informazione codificata nella sequenza degli amminoacidi del DNA passa ad una particolare sequenza di basi dell'RNA, 2) l'informazione dell'RNA passa ai polinucleotidi. 1)l'informazione codificata nella sequenza polipeptidica passa all'RNA 2) l'informazione dell'RNA passa ad una particolare sequenza complementare di DNA. 1) l'informazione codificata nella sequenza delle basi del DNA passa ad una particolare sequenza di amminoacidi, 2) l'informazione della sequenza di amminoacidi passa ai polipeptidi. 2. Durante la trascrizione: viene sintetizzata una catena polipeptidica complementare al filamento di RNA che funge da stampo. viene sintetizzata una molecola di DNA complementare al filamento di RNA che funge da stampo. viene sintetizzato un nuovo filamento di DNA complementare, secondo il modello semiconservativo della replicazione del DNA. una molecola di RNA complementare al filamento di DNA che funge da stampo. 3. l'RNA polimerasi effettua la sintesi del filamento di RNA: in direzione 5'-3' utilizzando come substrato nucleotidi con un gruppo fosfato, così generando un filamento complementare all'RNA stampo. in direzione 3'-5' utilizzando come substrato nucleotidi con un gruppo fosfato, così generando un filamento complementare al DNA stampo. in direzione 5′-3′ utilizzando i 4 tipi di riboNTP come precursori e copiando lo stampo di DNA. in direzione 3'-5' utilizzando come substrato nucleotidi con tre gruppi fosfato. 4. Definizione di geni interrotti: geni che contengono sequenze non codificanti, dette esoni, intercalate a a sequenze codificanti chiamate introni. geni che contengono sequenze non codificanti, dette introni, intercalate a sequenze codificanti chiamate esoni. geni che sono interrotti a causa di mutazioni non-senso. geni che non vengono tradotti correttamente in presenza di un codone di STOP. 5. I possibili codoni sono 64, mentre gli amminoacidi sono 20. Questo perché: Il t-RNA riconosce e quindi traduce solo 20 codoni. molti codoni sono solo ipotetiche combinazioni di basi che però non si ritrovano in natura. 20 codoni codificano per amminoacidi, gli altri sono codoni di stop. più codoni possono codificare per lo stesso amminoacido. 1. La fase di allungamento della catena polipeptidica termina quando: il fattore di rilascio si aggancia alla catena polipeptidica. Il codone stop richiama l'amminoacido stop. uno specifico tRNA, che porta il fattore di rilascio, si lega al codone di stop. Il fattore di rilascio si lega al codone di stop. 2. Il ruolo del del tRNA nella traduzione: trasportare gli amminoacidi al ribosoma. trasportare il DNA dal nucleo al ribosoma. fungere da stampo per la sintesi della proteina. intervenire nella maturazione del mRNA. 3. Le modificazioni post-traduzionali delle proteine sono tipicamente: proteolisi, glicolisi, poliadenilazione. fosforilazione, proteolisi, glicosilazione. proteolisi, splicing, fosforilazione. ATP-asi, defosforilazione,glicosilazione. 4. Il ribosoma è costitutio da: una subunità contenente RNA ribosomale e proteine. due subunità ciascuna contenete proteine ribosomali specifiche. due subunità ciascuna contenente RNA ribosomale e proteine. due subunità, la subunità maggiore contiene proteine e RNA ribosomale mentre la subunità minore contiene proteine. 5. Durante la traduzione la fase di allungamento: procede sempre in direzione 3'-5' lungo l'mRNA portando alla formazione di polisomi. procede sempre in direzione 5'-3' lungo il DNA e in modo discontinuo sul filamento lento. procede sempre in direzione 5'-3' lungo il DNA e l'mRNA si allunga dall'estremità amminica all'estremità carbossilica. procede sempre in direzione 5'-3' lungo l'mRNA e la catena polipeptidica si allunga dall'estremità amminica all'estremità carbossilica. 1. Una mutazione silente fa sì che: il gene mutato codifica per una proteina funzionale. il gene mutato codifica per una proteina non funzionale. il gene mutato codifica per una proteina con una nuova funzione. il gene mutato codifica per una proteina tronca. 2. Una mutazione con acquisto di funzione fa sì che: il gene mutato codifica un mRNA che non va incontro a splicing. il gene mutato codifica per una proteina tronca ma funzionale. il gene mutato codifica per una proteina con una nuova funzione. il gene mutato codifica per un nuovo mRNA perché il codice genetico è ridondante. 3. Una mutazione con perdita di funzione fa sì che: il gene mutato codifica un mRNA che non va incontro a splicing. il gene mutato codifica per una proteina tronca ma funzionale. il gene mutato codifica per un mRNA diverso perché il codice genetico è univoco. il gene mutato codifica per una proteina non funzionale. 4. Il fenomeno della traslocazione tra due cromosomi si verifica quando: un segmento di DNA si stacca dal proprio cromosoma e va ad inserirsi in un cromosoma diverso. cromosomi omologhi si rompono in due punti diversi e scambiano materiale. un segmento di DNA si stacca e si reinserisce nello stesso punto del cromosoma omologo. i cromosomi vanno incontro a non-disgiunzione meiotica. 5. Una mutazione del DNA porta alla trascrizione del codone UGA (codone di stop) invece dell'originale UCA (Serina), quindi: si tratta di una mutazione per spostamento della griglia di lettura (frameshift). siamo in presenza di una mutazione non senso. la proteina risultante sarà più lunga del previsto. si tratta di una mutazione silente. 1. Si definisce operone inducibile: un operone normalmente spento grazie alla presenza di un repressore che blocca stabilmente l'operatore. In presenza di un induttore il repressore si stacca e l'operone viene trascritto. un operone normalmente acceso. Il repressore entra in funzione solo in presenza di un corepressore che gli permette di bloccare la trascrizione dell'operone. un operone normalmente acceso che viene spento in presenza di lattosio. un operone normalmente spento che si accende solo in presenza di triptofano. 2. Si definisce operone reprimibile. un operone normalmente spento grazie alla presenza di un repressore che blocca stabilmente l'operatore. In presenza di un induttore il repressore si stacca e l'operone viene trascritto. un operone normalmente acceso. Il repressore entra in funzione solo in presenza di un corepressore che gli permette di bloccare la trascrizione dell'operone. un operone normalmente acceso che viene spento in presenza di lattosio. un operone normalmente spento che si accende solo in presenza di triptofano. 3. Si definiscono cambiamenti epigenetici: modificazioni irreversibili del DNA. modificazioni delle proteine istoniche che causano mutazioni stabili ed ereditabili. modificazioni dell'espressione genica che avvengono senza cambiamenti nella sequenza del DNA. modificazioni dell'espressione genica tipiche dei geni inducibili e reprimibili nei batteri. 4. Definizione di eucromatina: regioni del cromosoma contenenti sequenze indipsensabili per regolare la velocità di trascrizione dei geni. regioni del cromosoma contenenti geni interroti. regioni altamente condensate dei cromosomi che contengono geni trascrizionalmente inattivi. regioni cromosomiche non condensate che contengono geni trascrizionalmente attivi. 5. Definire il proteosoma: un grosso complesso proteico coinvolto nella degradazione delle proteine ubiquitinate. un grosso complesso proteico coinvolto nella sintesi proteica. un grosso complesso proteico presente nei lisosomi. un grosso complesso formato da ribosomi. 1. Il processo di introduzione di particelle di liquido dentro la cellula mediante la formazione di vescicole è detto. osmosi. diffusione facilitata. pinocitosi. trasporto mediato da carrier. 2. Trasporto attivo significa che: le molecole seguono attivamente il gradiente di concentrazione. è necessario fornire energia perché il trasporto avvenga contro gradiente di concentrazione. la pompa sodio-potassio espelle due ioni potassio e fa entrare tre ioni sodio. avviene in condizioni di equilibrio dinamico. 3. I fosfolipidi presentano una porzione della molecola idrofila perché: uno degli acidi grassi è sostituito da un fosfato e alcol polare che formano una porzione carica o polare. sono dei lipidi privi di acidi grassi. uno degli acidi grassi è sostituito da un fosfato, con carica elettrica negativa. presentano delle code di acidi grassi polari. 4. In accordo col modello a mosaico fluido, le membrane: sono costituite da lipidi che localmente assumono lo stato liquido. presentano proteine posizionate in maniera fissa intorno alle quali i lipidi si muovono fluidamente. sono costituite da un mosaico di diversi tipi di lipidi. le molecole dei fosfolipidi sono libere di muoversi lateralmente. 5. Se una cellula animale viene immersa in una soluzione ipertonica modifica la sua forma nel seguente modo: assorbe acqua per osmosi e si gonfia fino a scoppiare. perde acqua per osmosi e si raggrinzisce. perde acqua e si raggrinzisce a causa del movimento di ioni sodio dall'interno all'esterno della cellula. perde inizialmente acqua ma poi raggiunge un equilibiro tra l'interno e l'esterno della cellula. 1. Definire i microtubuli: filamenti di 8-12 nm di diametro presenti negli assoni dei neuroni. filamenti di 8-12 nm di diametro presenti nelle miofibrille. filamenti di 20-25 nm di diametro coinvolti nell'adesione tra cellule vicine. filamenti di 20-25 nm di diametro coinvolti in diverse funzioni citoscheletriche. 2. Definire i microfilamenti: filamenti di 5-7 nm costituti da due catene di molecole di actina intrecciate tra loro. filamenti di 8-12 nm di diametro presenti nelle miofibrille. filamenti di 20-25 nm di diametro coinvolti nell'adesione tra cellule vicine. filamenti di 20-25 nm di diametro coinvolti in diverse funzioni citoscheletriche. 3. Il centrosoma: struttura complessache contiene 2 centrioli circondati da materiale pericentriolare amorfo, opaco agli elettroni, in cui si ha la nucleazione dei microtubuli per la formazione del fuso mitotico. sono strutture cilindriche che contengono 9 fibrilleregolarmente spaziate ognuna delle quali è formata da 3 microtubuli. sottili organelli motori simili a peli chesi proiettano dalla superficie di vari tipi di cellule. formano le fibre del fuso per separare i cromosomi durante lamitosi. 4. La parete cellulare vegetale è: una struttura semirigida situata all'interno della cellula con la funzione di impalcatura citoscheletrica. una struttura semirigida situata all'esterno della membrana plasmatica composta da fibre di cellulosa immerse in una matrice di polisaccaridi e proteine. una struttura rigida situata all'esterno della membrana plasmatica composta da fibre di collagene e glicosamminoglicani. una struttura rigida situata all'interno della membrana plasmatica, costituita da alfa- e beta-tubulina. 5. I plasmodesmi sono: sottili organelli motori simili a peli chesi proiettano dalla superficie di vari tipi di cellule. filamenti di 8-12 nm di diametro presenti nelle miofibrille. formano le fibre del fuso per separare i cromosomi durante lamitosi. canalirivestiti di membrana plasmatica che permettono la comunicazione tra cellule adiacenti. 1. Il reticolo endoplasmatico liscio ha la funzione di: sintetizzare le proteine destinate a svolgere la loro funzione fuori dal citosol. sintetizzare lipidi, immagazzinare calcio, e idrolizzare glicogeno. demolire i perossidi tossici e degradare i materiali interni della cellula. idrolizzare le macromolecole grazie al pH acido interno e alla presenza di particolari enzimi. 2. I lisosomi sono: vescicole del diametro di 10 μm. vescicole del diametro di 1 μm. vescicole del diametro di 5 μm. vescicole del diametro di 0,1 μm. 3. La funzione principale del nucleolo: il nucleolo è coinvolto nella duplicazione del DNA. il nucleolo controlla l'attività del citoplasma. il nucleolo è il luogo dove inizia il montaggio dei ribosomi a partire dall'RNAribosomiale e dalle proteine. il nucleolo è responsabile della sintesi delle proteine all'interno del nucleo. 4. La principale funzione del reticolo endoplasmatico rugoso (RER) nelle cellule è: il RER è coinvolto nella fotosintesi delle cellule vegetali. il RER è responsabile della produzione di ATP nelle cellule. Il RER svolge un ruolo cruciale nella sintesi delle proteine destinate a funzioni extracellulari e intracellulari. il RER immagazzina lipidi all'interno delle cellule. 5. Le funzioni dell'apparato di Golgi sono diverse, tra le quali: l'apparato di Golgi sintetizza proteine e lipidi. l'apparato di Golgi modifica chimicamente le proteine provenienti dal reticolo endoplasmatico rugoso e le smista nei vari distretti cellulari. l'apparato di Golgi svolge il compito di modificare il materiale genetico e di sintetizzare i lipidi. l'apparato di Golgi permette lo smistamento degli ioni attraverso la membrana cellulare. 1. I mitocondri sono organuli che: permettono la produzone di ATP e possiedono tre zone distinte : una superficie cis, una zona intermedia ed una superficie trans. contengono del proprio DNA, i ribosomi ed enzimi deputati alla fotosintesi per produrre ATP. contengono del proprio DNA e i ribosomi per la sintesi proteica e grazie all'ATP-sintasi producono ATP. contengono l'ATP-sintasi che blocca il trasporto degli elettroni a livello delle creste mitocondriali per produrre ATP. 2. Nei mitocondri la catena respiratoria permette: l'eliminazione di anidride carbonica. la produzione di ossigeno. la sintesi degli zuccheri. la sintesi di ATP. 3. Il processo di fotosintesi clorofilliana fa sì che: l'energia luminosa venga convertita in energia chimica immagazzinata nelle molecole organiche. vengano prodotte molecole inorganiche a partire da ossigeno e acqua. una sequenza di eventi che utilizza l'energia luminosa per produrre 32 molecole di ATP e ossigeno. un processo svolto dai mitocondri nelle cellule animali e dai cloroplasti nelle cellule vegetali. 4. Il principale prodotto del ciclo di Calvin all'interno dei cloroplasti è: il glucosio. la Gliceraldeide 3-fosfato (G3P). l'ATP. il NADPH. 5. La struttura che si solleva in numerose pliche all'interno della membrana mitocondriale interna è: la membrana mitocondriale esterna. i tilacoidi. le creste mitocondriali. matrice mitocondriale. 1. I macrosistemi chimici di segnalazione cellulare si distinguono in: segnali autocrini, segnali giustacrini, segnali paracrini. segnali locali e segnali a distanza. segnali intracellulari e di superficie. segnali protein-chinasi, accoppiati a proteine G, segnali a canale ionico. 2. La cascata di trasduzione del segnale coinvolge i seguenti secondi messaggeri: ATP, ossigeno, ioni calcio. enzimi, fattori di trascrizione, proteine. AMP-ciclico, prodotti fosfolipidici, ioni calcio, ossido d'azoto. fosfatasi, chinasi, GTP-asi, ioni calcio. 3. Esistono tre tipi di recettori di superficie coinvolti nella via di segnalazione cellulare: i) recettori a canale ionico, ii) recettore ad attività protein-chinasica,iii) recettori accoppiati a proteina G. i) recettori agonisti; ii) recettori antagonisiti; iii) recettori di cooperazione. i) giunzioni strette, ii) desmosomi, iii) comunicanti. i) glicoproteine, ii) glicosamminoglicani, iii) proteoglicani. 4. I segnali autocrini: influiscono solamente sulle cellule adiacenti a quelle secernenti. diffondono verso le cellule vicine ed influiscono su queste. diffondono verso le cellule adiacenti. influiscono sulle stesse cellule che li hanno prodotti. 5. I recettori intracellulari: sono situati all'interno della cellula e rispondono a segnali fisici come la luce (fotorecettori nelle piante) oppure a segnali chimici che possono diffondere nella membrana plasmatica. sono situati all'interno della cellula e rispondono a segnali fisici come la luce (fotorecettori nelle piante) oppure a segnali elettrici che possono diffondere nella membrana plasmatica. si trovano sulla membrana palsmatica. svolgono varie funzioni fisiologiche. 1. Si definisce centromero: una proteina del nucleo che indica il centro della cellula. una regione del cromosoma vicino alla sua estremità. una regione del cromosoma che forma il fuso mitotico. una regione del cromosoma che tiene uniti due cromatidi fratelli. 2. Con il termine mitosi si definisce: il processo di divisione cellulare dal quale si ottengono due nuclei figli con lo stesso patrimonio genetico del nucleo della cellula madre. il processo di divisione cellulare dal quale si ottengono due nuclei figli con patrimonio genetico dimezzato rispetto al nucleo della cellula madre. la fase del ciclo cellulare in cui il DNA è copiato. la fase del ciclo cellulare che segue alla fase G1. 3. Nei procarioti la divisione cellulare prende il nome di. meiosi. scissione binaria. mitosi. apoptosi. 4. I cromatidi fratelli si separano durante: citodieresi. metafase. anafase. telofase. 5. Da chi viene effettuato il controllo del ciclo cellulare: DNA. chinasi ciclina-dipendente o Cdk. RNA. DNA-RNA. 1. Si definisce cariotipo: il corredo cromosomico caratteristico di ogni specie. l'insieme dei caratteri fisici di un individuo. il corredo cromosomico dei gameti maturi. un corredo cromosomico anomalo. 2. Con il termine meiosi si definisce: il processo di divisione cellulare dal quale si ottengono due nuclei figli con lo stesso patrimonio genetico del nucleo della cellula madre. il processo di divisione cellulare dal quale si ottengono due nuclei figli con patrimonio genetico dimezzato rispetto al nucleo della cellula madre. il processo di divisione cellulare dal quale si ottengono quattro cellule aploidi a partire da un cellula madre diploide. il processo di divisione cellulare dal quale si ottengono quattro cellule diplodi a partire da una cellula madre aploide. 3. Si definisce crossing-over: un evento di ricombinazione genica che accresce la variabiltà genetica. un evento di ricombinazione genica che avviene durante la mitosi. un evento di ricombinazione genica che durante la meiosi può causare aneuploidie. un evento coinvolto nell'assortimento indipendente dei cromosomi che accresce la variabilità genetica. 4. Il processo che porta all'unione dei due gameti si chiama: mitosi. fecondazione. meiosi. riproduzione. 5. I poliploidi: non hanno set di cromosomi completi. hanno meno di due set completi di cromosomi. hanno un set di cromosomi completi. hanno più di due set completi di cromosomi. 1. Si definisce apoptosi: tipo di morte cellulare programmata che si verifica normalmente durante lo sviluppo e nell'adulto. tipo di morte cellulare che porta la cellula a gonfiarsi e scoppiare a seguito di un di danno o evento avverso. tipo di modificazione del ciclo cellulare al quale vanno incontro le cellule tumorali. tipo di modificazione cellulare al quale vanno incontro i gameti durante la fecondazione. 2. Il recettore per fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) è coinvolto nei tumori perchè: rappresenta un fattore cancerogeno. se mutato causa un errore nella duplicazione del DNA che può essere trasmessa in maniera ereditaria. nelle cellule cancerose è inattivo e quindi non è più in grado di bloccare il ciclo cellulare nella fase G1. si comporta come un oncogene, rendendo la cellula tumorale particolarmente sensibile alla stimolazione del fattore di crescita. 3. I geni oncosoppressori codificano per proteine che: in condizioni fisiologiche regolano positivamente il ciclo cellulare e che nei tumori, a seguito di mutazioni, vengono attivate. in condizioni fisiologiche regolano negativamente il ciclo cellulare e che nei tumori, a causa di una mutazione, sono inattive. in condizioni fisiologiche inducono la necrosi cellulare e che nei tumori a causa di mutazioni portano ad apoptosi. in condizioni fisiologiche inducono l'apoptosi cellulare e che nei tumori a causa di mutazioni portano a necrosi. 4. La differenza principale tra i tumori sporadici e i tumori ereditari è: i tumori sporadici sono causati da mutazioni somatiche, mentre i tumori ereditari sono causati da mutazioni nella linea germinale. i tumori sporadici sono più comuni dei tumori ereditari. i tumori sporadici colpiscono principalmente gli organi interni, mentre i tumori ereditari interessano principalmente la pelle. i tumori sporadici sono più facili da trattare dei tumori ereditari. 5. Il processo coinvolto nei tumori e comporta la formazione di nuovi vasi sanguigni per fornire ossigeno e nutrienti al tumore è chiamato: angiogenesi. apoptosi. inibizione del sistema immunitario. instabilità del DNA. 1. Dati due individui con genotipi Aa e aa rispettivamente, nella F1 mi aspetto di trovare: tutti individui con fenotipo A. metà individui con genotipo Aa e metà con genotipo aa. 3/4 di individui con fenotipo A e 1/4 con fenotipo a. tutti individui con genotipo Aa. 2. La prima legge di Mendel afferma che: alleli di geni diversi si assortiscono indipendentemente l'uno dall'altro durante la formazione dei gameti. quando un individuo produce gameti, le due copie di un gene si separano, in modo che ogni gamete riceve una sola copia. la prima generazione filiale F1 presenta il carattere dominante nel 25% della progenie. gli individui ibridi della generazione F1 manifestano solo un dei tratti presenti nella generazone parentale. 3. La seconda legge di Mendel afferma che: quando un individuo produce gameti, le due copie di un gene si separano, in modo che ogni gamete riceve una sola copia. gli individui ibridi della generazione F1 manifestano una mescolanza dei tratti presenti nella generazone parentale. gli individui ibridi della generazione F1 manifestano solo un dei tratti presenti nella generazone parentale. alleli di geni diversi si assortiscono indipendentemente l'uno dall'altro durante la formazione dei gameti. 4. La terza legge di Mendel afferma che: gli individui ibridi della generazione F1 manifestano solo un dei tratti presenti nella generazione parentale. gli individui ibridi della generazione F2 manifestano una mescolanza dei tratti presenti nella generazione parentale. alleli di geni diversi si assortiscono indipendentemente l'uno dall'altro durante la formazione dei gameti. quando un individuo produce gameti, le due copie di un gene si separano, in modo che ogni gamete riceve una sola copia. 5. Un organismo omozigote: per un gene ha due alleli identici. per un gene ha due alleli diversi. per un gene ha due alleli recessivi. per un gene ha due alleli dominanti. 1. È più frequente che il crossing over avvenga tra loci che sono: molto lontani sul cromosoma. associati tra di loro sul cromosoma. alle estremità del cromosoma. nella regione centrale del cromosoma. 2. Il fenomeno della 'codominanza' si osserva quando: in una specie comapiono più di 4 alleli per lo stesso gene. due alleli di un locus producono due diversi fenotipi che comapiono entrambi negli eterozigoti. un individuo eterozigote mostra un fenotipo intermedio rispetto alle linea parentale. a causa dell'associazione genica due alleli non assortiscono in maniera indipendente. 3. Il fenomeno dell' 'epistasi' si osserva quando: due alleli di un locus producono due diversi fenotipi che compaiono entrambi negli eterozigoti. un gene influenza e sovrasta l'espressione fenotipica di un altro gene. geni multipli ed ambiente determinano la manifestazione di fenotipi complessi. incrociando linee pure ottenute da inbreeding si possono ottenere esemplari di qualità superiore. 4. Le principali evidenze sperimentali raccolte da Thomas Morgan nei suoi studi con la Drosophila melanogaster sono state: Morgan ha dimostrato l'esistenza di tre leggi di Mendel, smentendo l'idea dell'assortimento indipendente dei geni. Morgan ha identificato che i cromosomi contenevano sia DNA che proteine, suggerendo una nuova teoria sulla struttura genetica. Morgan ha scoperto l'epigenetica e dimostrato che l'ambiente può influenzare direttamente l'espressione genica. Morgan ha dimostrato che alcuni alleli non assortiscono in modo indipendente, suggerendo la presenza di geni collegati. 5. Thomas Morgan condusse esperimenti nella Drosophila che gli permisero di capire l'ereditarietà legata al sesso: Thomas Morgan ha scoperto un gene per il colore dell'occhio legato al cromosoma X nella Drosophila. Thomas Morgan ha dimostrato che i geni sulla X influenzano solo le femmine. Thomas Morgan ha scoperto che l'ereditarietà legata al sesso non è influenzata dalla presenza di geni sui cromosomi sessuali. Thomas Morgan ha dimostrato che un allele mutante per il colore dell'occhio è localizzato sul cromosoma Y. 1. Si distinguono tre categorie di epiteli in base alla loro funzione: rivestimento-sensoriale-ghiandolare. cubico-cilindrico-piatto. monostratificato-pluristratificato-pseudostratificato. rivestimento-endocrino-esocrino. 2. Lo strato più esterno dell'epidermider è: strato lucido. strato spinoso. strato corneo. strato basale. 3. Le ghiandole endocrine: riversano i loro secreti sulla superficie degli epiteli attraverso dotti escretori. riversano i loro secreti(ormoni) nel liquido intercellulare interstiziale o direttamente nel sangue. riversano i loro secreti direttamente sulla membrana basale. riversano i loro secreti direttamente nel circolo. 4. Gli ormoni peptidici sono: liposolubili, diffondono liberamente all'interno della cellula ed esercitano la loro azione dopo essersi legati a recettori localizzati nel nucleo. molecole derivanti da un acido grasso polinsaturo a 20 atomi di carbonio. ormoni derivati dagli amminoacidi. idrosolubili e legano un recettore di membrana. 5. L'epitelio degli alveoli polmonari e dei vasi sanguigni: è un epitelio pavimentoso semplice. è un epitelio cubico semplice. è un epitelio cilindrico semplice. è un epitelio pseudostratificato. 1. Il sistema nervoso si divide in : encefalo e midollo. gangli e nervi. autonomo e periferico. neuroni e cellule gliali. 2. Le spine dendritiche: sono protrusioni citoplasmatiche dell'assone che formano con i terminali dendritici le sinapsi. sono protrusioni citoplasmatiche del dendrite che formano con i terminali assonici le sinapsi. sono rigonfiamenti dei terminali assonici. sono rigonfiamenti del neurone. 3. Le cellule ependimali sono: cellule cubiche o cilindriche che rivestono le cavità del SNC (ventricoli e canale centrale) con produzione di liquido cefalorachidiano e svolgono anche il ruolo di cellule staminali neurali. forniscono la guaina mielinica agli assoni. guidano i neuroni durante lo sviluppo embrionale. cellule di difesa mobili di tipo fagocitico per rimuovere. 4. Le sinapsi: struttura deputata a trasmettere il messaggio nervoso tra cellule gliali. struttura deputata a trasmettere il messaggio nervoso tra cellule muscolari. struttura deputata a trasmettere il messaggio nervoso tra cellule del sangue. struttura deputata a trasmettere il messaggio nervoso tra cellule. 5. I neuroni sensoriali o afferenti: conducono le informazioni dai recettori sensoriali ai centri nervosi collocati nell'encefalo e nel midollo spinale. portano i comandi del SNC agli effettori, come le ghiandole o i muscoli. si occupano di integrare e immagazzinare le informazioni e di facilitare le comunicazioni fra sensori ed effettori. portano i comandi del SNP agli effettori, come le ghiandole o i muscoli. 1. I neuroni hanno due proprietà particolari: l'eccitabilità-la conduttività. l'elasticità-la conduttività. l'eccitabilità-la resistenza. la resistenza-l'elasticità. 2. Quali forze agiscono su una carica elettrica: la forza motrice-la forza elettrica. la forza di diffusione-la forza centripeta. la forza di diffusione-la forza elettrica. la forza chimica-la forza elettrica. 3. Nelle cellule nervose, la concentrazionedel sodio e del potassio è regolata da tre proteine di membrana: i canali del potassio- i canali del sodio- la pompa sodio-potassio. i canali del calcio- i canali del sodio- la pompa sodio-potassio. i canali del potassio- i canali del cloro- la pompa sodio-potassio. i canali del calcio- i canali del cloro- la pompa sodio-potassio. 4. Nello stato di riposo i canali per il sodio ed il potassiovoltaggio dipendenti sono: aperti. chiusi. semi aperti. semi chiusi. 5. I potenziali d'azione possono viaggiare lungo un assone rivestito di mielina a una velocità di circa. 120 m/s. 50 m/s. 70 m/s. 150 m/s. 1. Le caratteristiche del tessuto muscolare sono: contrattilità ed estensibilità- elasticità-eccitabilità. protezione-elasticità-eccitabilità. rivestimento-assorbimento-elasticità. assorbimento-contrattilità ed estensibilità- elasticità. 2. Le cellule satelliti: sono mioblasti quiescenti che non hanno capacità rigenerativa del tessuto muscolare. sono mioblasti quiescenti che hanno capacità rigenerativa del tessuto muscolare. sono miociti quiescenti che hanno capacità rigenerativa del tessuto muscolare. sono miociti quiescenti che non hanno capacità rigenerativa del tessuto muscolare. 3. I dischi intercalari si trovano: nel muscolo cardiaco. nel Muscolo liscio. nel muscolo scheletrico. nel muscolo involontario. 4. Il tessuto muscolare liscio: non si contrae. si contrae indipendentemente dalla volontà, grazie al sistema nervoso periferico. si contrae indipendentemente dalla volontà, grazie al sistema nervoso autonomo. si contrae dipendentemente dalla volontà, grazie al sistema nervoso autonomo. 5. Nella parte centrale del sarcomero ritroviamo: le linee z. la banda a. la banda i. actina e miosina. 1. Il tessuto connettivo propriamento detto comprende: lasso-denso-adiposo. cartilagineo-osseo-adiposo. adiposo-emolinfopoietico-denso. lasso-denso-emolinfopoietico. 2. La componente fibrillare comprende: proteine-fibre reticolari-fibre elastiche. fibre collagene-fibre reticolari-lipidi. fibre collagene-fibre reticolari-fibre elastiche. fibre collagene-acqua-fibre elastiche. 3. La fibronectina: media l'attacco dei condrociti al collagene. permette l'adesione delle cellule al substrato. permette l'adesione con il collagene. coinvolta in processi di cicatrizzazione e rimodellamento tissutale. 4. Il tessuto connettivo lasso: presenta scarse cellule(soprattutto fibroblasti) e scarsa sostanza fondamentale. si trova in particolare nel derma. altamente resistente alle sollecitazioni meccaniche. forma le strutture reticolari al di sotto degli epiteli di rivestimento degli organi che comunicano con l'esterno. 5. Il tessuto adiposo: svolge la funzione di deposito di Calcio. Svolge la funzione di deposito di lipidi. svolge la funzione di deposito di proteine. svolge la funzione di deposito di acqua. 1. Le ossa irregolari: includono le vertebre (che formano la colonna vertebrale), e le ossa dell'anca. sono sottili, appiattite e di solito incurvate. costituiscono tutte le ossa degli arti tranne la patella (rotula) e le ossa del polso e della caviglia. sono generalmente cubiformi e costituite principalmente da osso spugnoso. 2. L'osteone: unità strutturali dell'osso compatto costituito da lamelle ossee concentriche disposte attorno ad un canale centrale (canale di Havers) dove sono situati vasi sanguigni e nervi. parte interna ossa brevi, epifisi ossa lunghe. matrice disposta a formare una massa compatta. unità funzionale contrattile. 3. Le cellule presenti nel tessuto osseo sono: osteoblasti- condroblasti- osteociti. mioblasti-osteoblasti-osteociti. osteoblasti- osteociti-osteoclasti. condroclasti-condroblasti-condrociti. 4. Le cellule presenti nel tessuto cartilagineo sono: condroblasti-condrociti-condroclasti. fibroblasti-mioblasti-condroclasti. condroblasti-osteoblasti-condrociti. condroclasti-condrociti-osteociti. 5. La condrogenesi è: la formazione e l'accrescimento dei tessuti ossei che si verificanel periodo embrio/fetale e dopo la nascita. la formazione e l'accrescimento dei tessuti cartilaginei che si verificanel periodo embrio/fetale e dopo la nascita. la formazione e l'accrescimento dei tessuti nervosi che si verificanel periodo embrio/fetale e dopo la nascita. la formazione e l'accrescimento dei tessuti muscolari che si verificanel periodo embrio/fetale e dopo la nascita. 1. Le globuline rappresentano: 5% delle proteine plasmatiche. 35% delle proteine plasmatiche. 15% delle proteine plasmatiche. 45% delle proteine plasmatiche. 2. La concentrazione delle piastrine nel sangue è pari a circa: 400 000/mm3. 40 000/mm3. 500 000/mm3. 100 000/mm3. 3. Gli eosinofili: difendono l'organismo contro le infezioni con funzione fagocitaria. coinvolti nello shock anafilattico. aumentano in presenza di affezioni allergiche e di parassitosi. prodotti nei linfonodi, nella milza ed in altre strutture linfatiche. 4. Gli organi linfatici secondari comprendono: timo-midollo osseo. timo-midollo osseo-tonsille. timo-midollo osseo-milza. milza-le placche di Peyer-letonsille. 5. L'infiammazione: è una risposta immunitaria specifica, attraverso la quale l'organismo si difende in seguito al danneggiamento dei tessuti. è una risposta immunitaria aspecifica, attraverso la quale l'organismo si difende in seguito al danneggiamento dei tessuti. è un processo che coinvolge solo alcuni tessuti. ha una funzione di difesa simile a quella dei linfonodi. 1. La cellulosa è composta da legami: legami β(1,4) glicosidici. legami α(1,4) glicosidici. legami β(4,1) glicosidici. legami α(4,1) glicosidici. 2. Il vacuolo è: una cisterna tondeggiante rivestita da una membrana unitaria detta cromoplasto e contiene una soluzione acquosa detta succo vacuolare. una cisterna tondeggiante rivestita da una membrana unitaria detta protoplasto e contiene una soluzione acquosa detta succo vacuolare. una cisterna tondeggiante rivestita da una membrana unitaria detta tonoplasto e contiene una soluzione acquosa detta succo vacuolare. una cisterna tondeggiante rivestita da una membrana unitaria detta cloroplasto e contiene una soluzione acquosa detta succo vacuolare. 3. I cloroplasti: sono incolore e non contengono pigmenti. hanno colore Verde e contengono clorofilla e carotenoidi. hanno colore Giallo/Arancio/Rosso e sono ricchi in carotenoidi. hanno colore Verde/Arancio/Rosso e sono ricchi in carotenoidi. 4. Il parenchima di trasfusione: è specializzato per trasferimento di soluti a lunga distanza. è specializzato per il ricambio cellulare. è specializzato per la fotosintesi. è specializzato per trasferimento di soluti a breve distanza. 5. Gli stomi: consentono lo scambio gassoso fra interno ed esterno della pianta permettono la fuoriuscita di vapore acqueo e l'entrata di ossigeno e di anidride carbonica. consentono lo scambio gassoso fra interno ed esterno della pianta permettono la fuoriuscita di anidride carbonica e l'entrata di ossigeno e vapore acqueo. consentono lo scambio liquido fra interno ed esterno della pianta permettono la fuoriuscita di vapore acqueo e l'entrata di ossigeno e di anidride carbonica. consentono lo scambio liquido fra interno ed esterno della pianta permettono la fuoriuscita di anidride carbonica e l'entrata di ossigeno e vapore acqueo. 1. Le cellule della columella : si trovano nella foglia. circondano il tessuto vascolare del cilindro centrale. sono caratterizzate da accumuli di amido detti statoliti che percepiscono variazioni nella posizione di crescita. vanno incontro a gelificazione per costituire un lubrificante naturale che facilita lo scivolamento della radice nel terreno. 2. Il fusto è: è un organo che si sviluppa dal polo radicale dell'embrione. l'organo di sostegno delle piante vascolari e stabilisce il collegamento fra foglie e radici. è un organo ad accrescimento definito. è un organo deputato alla riproduzione. 3. La cuffia radicale è: la porzione terminale dell'apice radicale e costituisce un efficace tessuto di protezione del meristema apicale anche se spesso poche decine di file di cellule. un efficace apparato di assorbimento del meristema. assicura la formazione di nuove cellule per l'allungamento. una porzione di radice che contiene in embrione gran parte degli organi aerei della pianta. 4. La foglia è: è un organo deputato alla riproduzione. è un organo ad accrescimento definito. l'organo di sostegno delle piante vascolari e stabilisce il collegamento fra foglie e radici. è un organo che si sviluppa dal polo radicale dell'embrione. 5. I microsporangi sono contenuti: nella sacca pollinica. nei granuli pollinici. nello stilo. nell'ovario. |